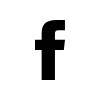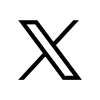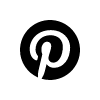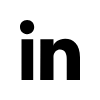Volumetrie pure, decorazioni asciutte o assenti, primato della funzionalità, adozione di nuovi materiali: dalla Casa del Fascio di Como alla stazione ferroviaria di Firenze, storia di un’esperienza che, dopo quasi un secolo e alcuni tentativi di damnatio memoriae, resta una presenza tangibile in Italia
La luce tra funzione ed emozione. Intervista a Hervé Descottes

National Museum of Qatar, Doha - © Iwan Baan, courtesy of L’Observatoire International
Il fondatore dello studio di progettazione illuminotecnica L'Observatoire International parteciperà alla Tavola Rotonda Light for Spaces all'interno di The Euroluce International Lighting Forum. Lo abbiamo intervistato sul suo percorso e sulle sue fonti di ispirazione, dalla vita quotidiana all'arte
Il suo lavoro è sotto gli occhi di decine di milioni di persone – pensiamo, per esempio, ai cinque milioni di newyorchesi e di turisti che ogni anno percorrono la High Line, la passeggiata verde realizzata sul tracciato di una ferrovia abbandonata di Manhattan, o ancora al milione e mezzo di visitatori annui della Fondation Louis Vuitton di Parigi – ma a notarlo è soprattutto chi sa dove dirigere lo sguardo. Agli altri resteranno una vaga sensazione di benessere, il piacere di camminare nelle sale di un museo ammirando opere ben illuminate, o ancora il senso di meraviglia provato davanti alle luci danzanti sulla facciata di grandi magazzini come Harrods, a Londra. Il lighting designer francese Hervé Descottes ha fondato a New York, nel 1993, l'Observatoire International: uno studio che ha come missione dichiarata quella di “illuminare il mondo” (è il claim che compare anche sul suo sito web) e lo fa con perizia e discrezione, sottolineando con un gesto progettuale misurato l'intenzione architettonica alla base di un edificio o di uno spazio. In un'intervista di qualche anno fa ha dichiarato che “il miglior intervento di lighting design in assoluto è quello che non si vede”. Gli abbiamo fatto qualche domanda in attesa di ascoltarlo (11 aprile - 14.00) all'Euroluce International Lighting Forum.
La luce è un sistema fenomenologico, cambia continuamente in risposta all’ambiente. È per questo che percepiamo come impalpabile, o addirittura invisibile, qualcosa che in realtà è un elemento tangibile. Una buona illuminazione dovrebbe adattarsi a ciò che la circonda, sviluppandosi in maniera armonica, e non esistere come uno strato a sé stante, slegato dalle caratteristiche dell’edificio, dal contesto sociale o dalla sostenibilità. L’errore più grande è progettare l’illuminazione concentrandosi sulle soluzioni possibili prima ancora di chiedersi perché si sta sviluppando quel particolare design invece di un altro.
Sono entrambi importanti. Quando creiamo i nostri progetti, all'inizio ci sforziamo di capire che impatto la sensibilità avrà sull'ambiente e come l'illuminazione interagirà con essa su un piano concettuale. Ci sono tre elementi chiave da considerare: il contesto, l'architetto e/o il designer e gli utenti. Ci chiediamo sempre perché stiamo disegnando qualcosa e come questi elementi possono aiutarci a rispondere alle seguenti domande: qual è la specificità di uno spazio o di un luogo (per esempio, un progetto in Medio Oriente non può essere concepito nello stesso modo di uno in Europa)? Quali erano le intenzioni dei designer o degli architetti nel dare forma alla loro creazione? E infine, come sarà usata in futuro? Il nostro obiettivo è tradurre questi “perché” nel nostro design e nei nostri progetti. Il mio team, formato da designer, tecnici, creativi e ricercatori, collabora nella creazione di una visione della luce che sia il più possibile organica e onnicomprensiva. Ognuno di loro, poco importa che si tratti di membri del team interno o di consulenti esterni, porta in dote un suo punto di vista e un'esperienza unica.
Gli architetti con cui ho lavorato sono stati una fonte di ispirazione incredibile. Ognuno ha una sua visione personale e unica della materia, perciò ogni collaborazione è diversa dalle altre. è qualcosa che ha anche un significato personale per me, le relazioni che costruisco sono davvero importanti. Con alcuni di loro ho lavorato per anni, sviluppando un legame solido basato sulla fiducia e sulla comunicazione. Non parlerei di che cosa ho imparato da loro ma piuttosto di uno scambio. L'ispirazione scorre in entrambe le direzioni ed è radicata nel dialogo, che mi permette di capire meglio le intenzioni dei progettisti. Loro si fidano di me quando mi chiedono indicazioni sull'illuminazione, e io ripago la loro fiducia mostrando la delicatezza dell'architettura e del progetto.
La mia ispirazione, così come i miei progetti, sono il risultato di una varietà e pluralità di influssi. Sono stato ispirato a lungo e profondamente dall’architettura, dal cinema, dalla fotografia e dalla natura – tutti ambiti che nella loro intima essenza sono collegati alla luce. Adesso mi concentro di più sulle questioni sociali e sulla sostenibilità, cercando di tradurre queste preoccupazioni nel mio lavoro. Conduco una vita molto intensa, poiché dirigo progetti e team di lavoro, viaggio attraverso l’Europa, gli Stati Uniti e L’Asia, cercando di conciliare il tutto con la famiglia e una ricca vita sociale. Le persone vicine a me mi ispirano moltissimo.
Penso che gli artisti visivi, e soprattutto gli “artisti della luce”, siano stati una importante fonte di ispirazione per me – penso in particolare al movimento Light and Space e a James Turrell (con cui tra l’altro ho collaborato su diversi progetti), con la sua vasta ricerca sulla percezione. Da bravo Europeo, inoltre, la mia estetica è stata fortemente plasmata da pittori classici come Georges de La Tour, Caravaggio e i Maestri della Luce, ma anche da pittori moderi come Rothko.
La sfida principale era, naturalmente, trasmettere l’idea di un’illuminazione invisibile – capace di evidenziare un percorso e un luogo iconico con discrezione, quasi come se fosse un gesto magico – e allo stesso tempo tradurre questa visione in una realtà tecnica. L’obiettivo era di creare un ambiente sicuro e accogliente conservando un senso di mistero occultando tutte le sorgenti luminose. Di notte, soprattutto all’esterno, la luminosità e il contrasto sono amplificati per via dell’adattamento dei nostri occhi all’oscurità, perciò bisogna evitare l’alto contrasto ed evitare di avere la sorgente luminosa a vista per poter vedere davvero l’effetto della luce. Un’altra sfida è stata camminare lungo parecchi isolati del West Side di Manhattan e riscoprire la città da quell’altezza senza dar vita a un tunnel di luce. La chiave è stata ridistribuire luci più morbide lungo tutto lo spazio.
Non credo di aver scelto consapevolmente questa strada – è lei, semmai, che ha scelto me. Negli anni ottanta, a Los Angeles, ho avuto l’opportunità di incontrare delle persone che lavoravano in questo ambito e di essere ispirato da loro. E’ stata una rivelazione che mi ha aperto gli occhi su un mondo fatto di sensibilità del quale prima di allora non avevo consapevolezza. Questa nuova sensibilità alla luce mi ha fatto sentire come se avessi scoperto un universo completamente nuovo. Più tardi, quando sono tornato in Francia, ho preso parte alla ristrutturazione dell’ala Richelieu del Louvre e da lì tutti pezzi hanno cominciato ad andare al loro posto. A quei tempi i lighting designer erano in primis degli ingegneri, all’opposto di quello che succedeva negli anni Sessanta e Settanta quando erano per la maggior parte architetti. Quello che interessava a me era spingere il concetto del lighting design in una direzione più creativa – più simile, per esempio, al lavoro di un direttore della fotografia.
Credo che mi piacerebbe studiare le città del futuro e capire come creare un sistema quasi organico in cui ciascuna fonte di energia sia complementare e di supporto alle altre.

Lo spazio di gioco è una cosa seria
Non solo luoghi del divertimento, ma veri propri cardini della socialità dove gli individui si incontrano, creano legami e costruiscono fiducia


La seconda edizione dei Tavoli di Lavoro (Eco) Sistema Design Milano
Dal ruolo delle politiche culturali e della formazione, alla nascita di nuovi pubblici e pratiche emergenti, fino alle reti innovative tra territori e design. Il racconto della giornata di lavoro di giovedì 25 settembre nell’ambito del progetto di ricerca promosso dal Salone del Mobile e dal Politecnico di Milano