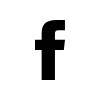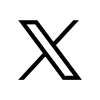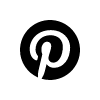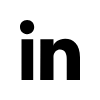Acquisti intelligenti e sostenibili: come sfruttare al massimo il bonus elettrodomestici e come richiederli. Requisiti, importi e limiti da conoscere

Raffaella Mangiarotti
Funzione, estetica, ergonomia ma anche tanta empatia: questi i parametri fondamentali di ogni progetto per Raffaella Mangiarotti
Raffaella Mangiarotti si è laureata in Architettura al Politecnico di Milano con Tomàs Maldonado. All’attività di progettazione ha sempre abbinato la didattica ed è ricercatore confermato. Inizialmente si è dedicata al product design, associata con Matteo Bazzicalupo sotto la sigla deepdesign (la Triennale di Milano ha dedicato al loro lavoro, nel 2008, la mostra monografica “L’anima Sensibile delle Cose”, curata da Cristina Morozzi). In seguito, ha privilegiato il disegno degli arredi e degli oggetti, progettando, tra gli altri, per Atipico, b-line, IOC, Manerba, Serralunga, Woodnotes. È stata art director di Serralunga (2010-2015), Manerba (2014-2018), IOC (dal 2018).
Appartenente a quella che definiamo la generazione “post-maestri”, Raffaella rappresenta, senza dubbio, una figura anomala nel panorama del design italiano per il suo approccio sempre mirato e mai decorativo che la tiene, fortunatamente, a grande distanza dagli attuali eccessi dello stylism.
Delle donne architetto o designer si è parlato, ma poco, pochissimo si è scritto. Da sempre: basti citare Charlotte Perriand o a Eileen Grey. Solo in questi ultimi anni abbiamo avuto l’esatta percezione del loro valore perché è stata forte la volontà di ripercorrerne la storia, raccontandola in modo autonomo da Le Corbusier: si dice che l’evidente qualità della Grey e della Perriand desse quasi fastidio a Le Corbusier. Atteggiamento specchio di un’epoca in cui ci si aspettava dalle donne un ruolo non autonomo, ma ancillare. Fortunatamente sono vissuta in un mondo più evoluto, ma comunque ancora prevalentemente maschile: dominavano i grandi maestri, tutti rigorosamente uomini. Alcune figure femminili esistevano, ma erano poco evidenti. Forse la più riconosciuta è stata Cini Boeri. Io appartengo, alcune generazione dopo, alla sua stessa scuola, quella di Marco Zanuso. Sia lavorando con Zanuso, sia poi con Franceso Trabucco, non mi sono, però, mai sentita discriminata perché donna: erano le idee a valere. Anzi, nello studio di Trabucco, ero rapidamente stata nominata “capoprogetto” e dovevo coordinare un gruppo di designer (maschi). Ci sono invece situazioni molto specifiche in cui ti senti ancora penalizzata. Ad esempio, quando si discute di aspetti tecnici: le soluzioni tecniche proposte da una donna creano più dubbi rispetto alle stesse proposte da un uomo. Tuttavia, più l’interlocutore è preparato e meno ciò si verifica: paradossalmente gli ingegneri, che dovrebbero essere i più critici, ti ascoltano con attenzione, non ponendo mai differenze di genere. Del resto, si sa, i preconcetti sono figli dell’ignoranza. Proprio per questo noi donne ci sentiamo obbligate a rendere conto della significatività del nostro lavoro molto più sovente.
No, non credo che l’identità di genere possa aver influenzato le mie scelte. Ho lasciato prima lo studio di Zanuso e poi quello di Trabucco perché desideravo esprimermi in autonomia, capire come sarebbe cambiato il mio pensiero e il mio linguaggio. Con Matteo Bazzicalupo ci siamo conosciuti perché eravamo entrambi stati chiamati a collaborare con la rivista Modo. Così abbiamo scoperto di esserci laureati con lo stesso professore e di avere una naturale affinità di pensiero. Abbiamo lavorato insieme, ma non siamo mai stati una coppia. Lavorare insieme significa per me confrontare idee che nascono da punti di vista e sensibilità diverse. Penso sia stimolante, ma mi piace anche lavorare da sola perché serve a chiarire a se stessi il proprio modo di ragionare.
Dopo aver progettato numerosi prodotti industriali destinati alla massa, ho sentito il bisogno di fare qualcosa di diverso. Allo stesso tempo Matteo, il mio socio in deepdesign, voleva trasformare un oggetto che avevamo disegnato in una attività imprenditoriale. Io però non sentivo quello stesso slancio. Così abbiamo deciso di dividere le nostre strade: lui ha sviluppato il suo prodotto e invece io ho continuato a disegnare. In un primo tempo ho progettato mobili e accessori, ma senza una vera commessa. Dovevo capire cosa vuole dire ideare un mobile (disegnare un tostapane o una sedia non è veramente la stessa cosa). Dovevo capire il mondo del mobile, i suoi trend e le sue dinamiche, e soprattutto dovevo capire cosa personalmente volessi raccontare. Pochi anni dopo, grazie a Carlo Manfredi, credo il miglior consulente strategico che abbia mai incontrato, mi è stata offerta la direzione creativa di Serralunga. In fondo non mi sentivo adatta a quel ruolo e così mi sono affidata più al suo intuito che del mio. Tutt’oggi lo considero il mio mentore, oltre che un grande amico.
Sì, da sempre. Sono cresciuta in una casa con una boiserie di legno che ricordava le opere di Wright, ma era arredata con mobili di spirito nordico. Quando mia madre mi portava a Milano non era per fare shopping, ma per andare da De Padova! Ricordo che ci stavamo ore: conoscevo il negozio a memoria, piastrella per piastrella. A un certo punto Inger Klingenberg, architetto danese che lavorava con Madddalena De Padova, cominciò addirittura a venire a casa nostra, a Pavia, magari per pranzo. Mio padre invece è stato uno dei primi ingegneri nel settore informatico, era dirigente alla Necchi e poi consulente per Olivetti. Nel suo studio non mancavano le litografie Olivetti e i portacenere di Sottsass, in casa la macchina da cucire era quella di Zanuso. Questi sono stati i miei riferimenti di partenza. Quando, molti anni più tardi, sono arrivata in Finlandia e ho scoperto la produzione di Woodnotes, in fondo l’ho trovata familiare: l’avevo vista, un ventennio prima, da De Padova. Così, con Ilkka Suppanen, siamo andati a trovare Mikko Puotila, direttore creativo e proprietario di Woodnotes, e abbiamo iniziato a lavorare per lui. È nata la sedia “Siro”: era la prima volta che Ilkka e io lavoravamo insieme, e “Siro” è l’esito di una lunga discussione. Alla fine, credo rappresenti una buona sintesi tra l’essenzialità finlandese e la sensualità italiana. L’influenza nordica, mediata dal calore italiano, identifica un mio codice espressivo (credo che sia assai evidente nei miei ultimi lavori per IOC).
Mi interessa molto in effetti il rapporto tra lo spazio del lavoro e quello della vita quotidiana e il modo in cui ho interpretato gli arredi che tu citi credo renda evidente il mio pensiero. Diversi anni fa, quando ho iniziato a occuparmi del tema dell’ufficio, i mobili erano belli, ma con un’anima tecnica, molto fredda, che non condividevo. Proprio perché quello che esisteva non mi piaceva, ho pensato che potesse essere una sfida interessante. Ho cominciato allora a ragionare su che tipo di soluzione avrebbe potuto coinvolgermi e, conseguentemente, proprio immaginando un mio luogo di lavoro ideale, ho disegnato mobili sì funzionali, ma anche confortevoli, accoglienti ed empatici. Da allora non uso nemmeno più la parola ufficio: per me è una parola distraente. Mi piace semplicemente parlare di persone che lavorano e pensare a come farle stare bene mentre lavorano. A volte, quando mi sembra di aver trovato una soluzione interessante, dico ai miei clienti “Proviamola, proviamola subito, qui, con le persone che collaborano con noi!”. Ecco che il mio progettare non si concretizza in mobili destinati ad altri (mobili da vendere), ma piuttosto in mobili per me, per noi, ora, mentre stiamo lavorando per voi. Passando la maggior parte del tempo in un ambiente professionale, questo deve necessariamente essere gentile e bello. Deve essere confortevole soprattutto “mentalmente”, comunicarmi cioè un comfort non solo fisico, ma visivo, acustico, tattile, in sintesi psicologico. Comunque, devo ammettere che hai citato due aziende che ho nel cuore: Manerba è stata la mia prima esperienza in questo settore. Quando sono arrivata facevano mobili destinati a un ufficio “classico”: mi è venuta voglia di rinnovare tutto, dai colori ai prodotti, alle collaborazioni con i designer. Ho iniziato dalle piccole cose, tante piccole cose portate avanti con ritmo veloce e continuo, stando sempre attenta agli investimenti e ai ritorni. Non ho mai amato fare il passo più lungo della gamba: già mia nonna era una imprenditrice e da lei ho appreso il valore del denaro. Entrata in Manerba come designer, in breve mi sono trovata a fare il direttore creativo. È stato un processo molto naturale: in tre anni siamo riusciti a dare una nuova identità al brand e a far crescere il fatturato. Successivamente mi hanno chiamata in IOC (gruppo Lema). Mi interessava affrontare un gruppo che si occupava sia della casa sia dell’ufficio perché era, in qualche modo, la mia dimensione ideale: un lavoro al confine tra la lo spazio domestico e quello lavorativo. Ho quindi deciso di accettare la nuova sfida: devo ammettere che non è facile passare da una realtà all’altra soprattutto perché mi affeziono alle persone. In ogni art direction, alla fine, mi sento un poco “adottata” da una famiglia.
Sia il divano “Ghisolfa” sia il divisorio “Monforte” rispondono a questi requisiti, ma sono anche oggetti mobili che consentono di riconfigurare lo spazio a seconda delle esigenze che cambiano. “Monforte”, ad esempio, è costituito da un insieme di tubi tessili che si snodano secondo un sistema simile a quello della catena della bicicletta: si può articolarlo a seguire qualsiasi geometria. Credo che un progetto così flessibile sia veramente espressione del nostro tempo che è fluido, senza nulla di definito. In questi ultimi anni mi sono trovata spesso a lavorare alla scala dello spazio interno, sia con gli show-room per Smeg, a Milano e Londra, sia con diversi progetti allestitivi per IOC. Sono naturalmente orientata verso gli spazi aperti: il mio ideale architettonico rimane la pianta libera di Mies van der Rohe ove l’uso delle pareti è intelligente e parsimonioso. Pareti, spesso arricchite con materiali inusuali, che non delimitano gli spazi, ma piuttosto orientano i flussi e creano uno scenario per gli arredi. Così come la luce, considero lo spazio un antidepressivo naturale. In questa “libertà” trovo corretto disegnare arredi che facciano da contrappunto: spazi-nicchia in cui ritrovare la dimensione dell’intimità. È un po’ come ripararsi sotto le fronde di un albero e guardare il cielo. Gli spazi e i mobili che disegno lavorano sempre su queste due dimensioni: l’apertura e la delimitazione visiva. L’essenzialità e la sensualità. Una sensualità determinata non solo dalle forme, ma dalla palette cromatica, dalla tattilità di un tessuto, dalla piacevolezza di un materiale naturale, da una soluzione acustica che privilegi l’intimità. Un insieme di aspetti che, a mio giudizio, determinano la piacevolezza finale di un progetto.

Arabia Saudita, terra di nuovi equilibri
L'Arabia Saudita è il più grande mercato FF&E (Furniture, Fixture and Equipment) della regione MENA (Middle Est and North Africa). Nel 2024 ha raggiunto un valore pari a 7,2 miliardi di dollari, alimentato dalla diversificazione economica, dalla rapida espansione demografica e dalle riforme del programma strategico Saudi Vision 2030.


“Salone Raritas”: il nuovo percorso espositivo dedicato al design in edizione limitata e all’alta manifattura creativa
Alla 64ª edizione della Manifestazione debutterà Salone Raritas. Curated icons, unique objects, and outsider pieces: primo confronto diretto tra mondo del design in edizione speciale, dell’antiquariato e dell’alto artigianato con il mercato professionale del progetto (architetti, interior designers, developer, operatori dell'hospitality e del contract, etc). Gallerie d’eccellenza e un’audience internazionale si incontreranno in una piattaforma dalla forte visione curatoriale, concepita per attivare relazioni di lungo periodo e generare opportunità di business.



 Storie
Storie