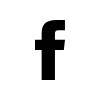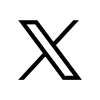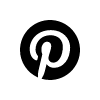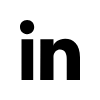Modulari, confortevoli, dall’estetica ricercata e con dettagli sartoriali: ecco una selezione di elementi d’arredo pensati per rendere ogni ambiente domestico davvero unico
Alejandro Aravena: “loro” siamo “noi”, la lezione della pandemia

Alejandro Aravena. Ph. Credits Andrea Avezzù. Courtesy La Biennale di Venezia
Per l’architetto cileno l’emergenza ci ha mostrato che se ci sono persone che non riescono a seguire una semplice raccomandazione sanitaria, allora abbiamo tutti un problema. Questo ci deve far riflettere sul valore del bene comune, a cui dovrebbero tendere le regole del vivere insieme. Con conseguenze sull’uso degli spazi e sulla progettazione urbana
Alejandro Aravena (Santiago del Cile, 1967), architetto, Premio Pritzker, Leone d’Argento a Venezia, direttore di Elemental, ha messo la dimensione sociale al centro del proprio lavoro. Agli Open Talks del “supersalone”, ai quali ha partecipato con una lectio magistralis, ha portato la propria riflessione sul vivere insieme. Non a caso è il tema della Biennale Architettura, a Venezia fino al 21 novembre: “How will we live together?”, alla quale Aravena, con la squadra di Elemental, ha partecipato portando la propria personale declinazione della domanda (e risposta). Come vivremo insieme, cileni e mapuche? Costruendo luoghi per conoscersi (Künü). Costruendo luoghi per parlare (Koyaü-we). Il risultato è progetto che esplora un percorso alternativo alla violenza insita nello scontro in corso tra i due gruppi: uno spazio aperto al dialogo. Una strada che è solo una delle possibilità dell’architettura.

Elemental, Ph. Credits Andrea Avezzù. Courtesy La Biennale di Venezia
Di certo cambierà, ma questo non è il punto. Perché è rilevante solo per i Paesi cha hanno una pianificazione, cioè una minoranza. La vera sfida è comprendere le forze che governano la spontaneità dell’ambiente costruito. La pandemia ha messo alla prova in un modo molto brutale le cose semplici: stare a casa e lavare le mani, per esempio, è qualcosa di garantito per il mondo sviluppato, ma non per la maggior parte degli abitanti del pianeta. Tutti dicono che questa pandemia non sarà l’ultima: facciamo in modo che per la prossima le semplici raccomandazioni come “state a casa” o “lavatevi le mani” trovino persone che abbiano a disposizione acqua potabile, e una casa. Inoltre, vivendo l’emergenza ci siamo resi conto che in una società non facciamo più cose “per loro”. Il “loro” è stato rimpiazzato dal “noi”. Se ci sono persone che non riescono a seguire una semplice raccomandazione sanitaria, allora abbiamo un problema tutti, non solo “loro”. Allo stesso modo la povertà è qualcosa che soffrono “loro”, ma le sue conseguenze, con le persone disperate perché non riescono a guadagnarsi da vivere, creano un problema alla collettività.
Più che la pianificazione, che significa che tu vuoi qualcosa e fai in modo che gli altri ti seguano, il punto è capire quali siano le forze in gioco e incanalarle più che controllarle, rimpiazzarle o reprimerle. Possiamo usare queste forze come parte della soluzione, non del problema. Le sfide con cui abbiamo a che fare sono troppo grandi. Bisogna comprendere la propria posizione nell’insieme più che aspettarsi di avere followers o compratori. La pianificazione è una forza debole.
Le persone vogliono avere accesso alle opportunità, per esempio. Per questo vengono nelle città. Ma le loro azioni individuali, pur con le migliori intenzioni, non possono garantire il bene comune. Una pianificazione, un’azione di governo, è prendersi cura del bene comune, perché spontaneamente non può essere garantito. Per dare qualche numero, a Manhattan, la proporzione tra spazi pubblici e privati è di 1 a 1. Qualcuno ha deciso che le strade, i marciapiedi, i parchi, le piazze non potessero essere usati dai privati ma fossero destinati all’uso pubblico. Nel caso di un insediamento informale questo numero scende: è di 1 a 10. Questo significa che hai un vicolo di accesso alla tua casa se sei fortunato. Qui il bene comune non è stato garantito. A questo servono le regole del vivere comune. Un altro aspetto è focalizzare le risorse verso chi, una famiglia o un individuo, da solo non ce la fa. È la definizione di una public policy: fare quello che le persone non riescono a fare per conto proprio. Se si crea uno spazio e si permette alla gente di entrare nel sistema, saranno parte della soluzione e non del problema. Questa è stata una delle conclusioni più importanti della conferenza Habitat 3 a Quito (Ecuador), che ha adottato la new urban agenda per i prossimi 20 anni (si è tenuta nel 2016, ndr). Nei documenti la chiamano “urbanistica porosa”: un sistema aperto, dinamico, che assicura spazio per tutti, assicura la diversità.

Elemental, Ph. Credits Andrea Avezzù. Courtesy La Biennale di Venezia
La pandemia, l’emergenza climatica, la distruzione politica e sociale. Tutte e tre hanno in comune il dibattito tra l’individuo e la collettività. La libertà del primo, di seguire i propri sogni, di realizzare il proprio destino, di capire il motivo per cui è qui, ora è una minaccia. Non è così chiaro che tu abbia il diritto di fare qualsiasi cosa tu voglia fare. Devi bilanciarlo con il bene comune e quindi forse alla fine non sei più così libero. E questo non è così male. Al posto di concentrarti sul tuo futuro, ti chiedi quale sia il tuo ruolo nell’insieme, come tu possa dare un contributo. L’autoregolazione è cruciale per questo. E la consapevolezza dell’insieme è diventata evidente. Nel momento in cui tu identifichi la minaccia al bene comune, alla collettività, e comprendi il tuo posto nell’insieme, allora raggiungerai un qualche tipo di equilibrio. Le due cose vanno insieme: il tuo destino e quello del resto della squadra.

Elemental, Ph. Credits Andrea Avezzù. Courtesy La Biennale di Venezia
Più che di responsabilità parlerei di possibilità. Nel senso che al centro del design e dell’architettura c’è uno strumento molto efficace: il potere della sintesi. Domande complesse hanno bisogno di sintesi. Una questione complessa ha molte dimensioni: l’ambiente costruito, per esempio, porta con sé richieste funzionali, molto pragmatiche, misurabili, budget, scadenze, cornici legali da rispettare. Sono condizioni necessarie ma non sufficienti perché c’è anche la dimensione intangibile della condizione umana: desideri, paure, aspetti simbolici. Non c’è l’uno e senza l’altro: esistono entrambi allo stesso tempo. È questa varietà così complessa di forze in gioco che informa la forma degli spazi. Perché è questo quello che facciamo: diamo forma ai luoghi dove vivono le persone. Né più né meno. I marciapiedi, le strade, gli edifici, i parchi: devono avere una forma. E a seconda della forma che si riesce a imprimere si può migliorare la qualità della vita. Bisogna identificare quello che è rilevante, cruciale, le priorità. E poi buttarsi nella proposta, nel progetto, anche con qualche rischio.
Al centro della nostra pratica c’è la capacità di organizzare le informazioni in una proposta che non è lineare. Nelle sfide più grandi, nelle richieste più difficili, dobbiamo abituarci al fatto che non possiamo controllare tutte le variabili, ma possiamo trovare i benefici relativi e minimizzare gli impatti negativi. Questo è il nostro ruolo. Preferisco questo alla parola “responsabilità”.