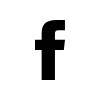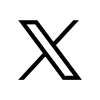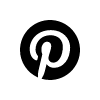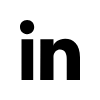Acquisti intelligenti e sostenibili: come sfruttare al massimo il bonus elettrodomestici e come richiederli. Requisiti, importi e limiti da conoscere
Bjarke Ingels: l’architettura come processo in divenire

Bjarke Ingels - Ph. Blaine Davi
Conversazione con l’architetto danese, protagonista (10 aprile alle ore 11.00) del programma culturale “Drafting Futures. Conversations about Next Perspectives” a cura di Annalisa Rosso, Editorial Director & Cultural Events Advisor, ci invita a riflettere su come materialità, tecnologia e interazione umana possono ridefinire il futuro dell’urbanistica
L’architettura non è solo costruzione, ma un atto di rivelazione. In questa intervista, Bjarke Ingels racconta il suo approccio al progetto, il legame tra architettura e percezione. Per lui, costruire significa dare nuove possibilità non solo alla materia, ma anche all’assenza di essa, modellando l’invisibile e trasformando lo spazio in un’esperienza che cambia il modo in cui vediamo e viviamo il mondo.

The Spiral, Bjarke Ingels - Ph. Laurian Ghinitoi
Ritengo che, in molti modi, un progetto serva a sbloccare possibilità che prima non esistevano o di risolvere problemi che non erano stati identificati o affrontati. Nasce da una condizione esistente e, al contempo, genera una nuova possibilità a partire da essa. In questo senso, ogni progetto rende evidente qualcosa che prima non era percepibile. Analogamente, l’arte che amo e che mi emoziona è quella che amplia la mia percezione del mondo. Un brano musicale, ad esempio, può rivelarmi una bellezza o un’armonia latente in suoni che avrei potuto scartare come dissonanti o come semplice rumore. Oppure può essere una fotografia o un film che mi spinge a cogliere il significato nel quotidiano o la poesia nascosta nella routine.
Ciò che accomuna tutte queste forme d’arte è la loro capacità di affinare la percezione, di aprire occhi e orecchie, di risvegliare i sensi alla bellezza, alla poesia e al significato racchiuso nei momenti ordinari. Non puoi più guardare o ascoltare il mondo senza notare questa bellezza.
Credo che questo valga anche per l’architettura, i progetti architettonici che in qualche modo ti rendono consapevole di qualcosa che c'era già, ma una volta che l'hai elevato, evidenziato o costruito sopra, ora diventa palesemente ovvio. Un esempio emblematico è il termovalorizzatore di Copenaghen, era destinata a essere la centrale termoelettrica più pulita al mondo. Così pulita che il vapore che esce dal camino è più pulito dell'aria di Copenaghen.Abbiamo trasformato la facciata in un elemento accessibile e godibile da tutti, e il tetto in un luogo dove camminare, scalare e sciare. Invece di limitare l'uso della facciata e del tetto dell'edificio alle loro funzioni tradizionali, li abbiamo trasformati in spazi pubblici dove le persone possono interagire e divertirsi. Abbiamo preso un'idea esistente e l'abbiamo reinventata per renderla accessibile a tutti.
Credo che, più di ogni altra cosa, il nostro lavoro di architetti consista nel confrontarci con luoghi che inizialmente non conosciamo e con committenti che svolgono attività diverse dalla nostra. Dopotutto, gli architetti sanno già progettare i propri edifici.
Noi, invece, lavoriamo per insegnanti, medici, artisti, curatori, musicisti, ovvero per persone che operano in ambiti di cui non abbiamo una conoscenza diretta. Il primo passo, quindi, è sempre quello di educarci: ascoltare, osservare, comprendere cosa rende unico un determinato luogo, quali sono le sue criticità, cosa distingue un’attività specifica e quali sono le sue sfide, ma anche quale direzione sta prendendo quel luogo o quell’attività e ambito.
Cerchiamo i migliori esperti nei rispettivi settori e trascorriamo del tempo con coloro che utilizzeranno quello spazio in futuro. È così che riusciamo a cogliere l’evoluzione del mondo. Perché, se il mondo è in continua trasformazione, la risposta giusta oggi potrebbe non esserlo più domani. Addirittura, potrebbe cambiare la domanda stessa. Continuare a proporre la stessa risposta a una domanda superata significa semplicemente rispondere alla domanda sbagliata.
Il nostro processo, dunque, si basa innanzitutto sulla comprensione critica del contesto e delle esigenze specifiche. Da lì, ridefiniamo la questione principale. Perché una volta identificata la domanda cruciale – qual è il problema e qual è il potenziale – il resto del processo consiste semplicemente nel rispondere ad essa.
Quest’anno, in qualità di guest editor di Domus, ho scritto un manifesto ossimorico, perché penso che molto spesso l'ossimoro, l'idea che incarna le contraddizioni, sia la strada da seguire. La tensione interna che deriva da un ossimoro, come la sostenibilità edonistica o l'utopia pragmatica, è la forza trainante di molto del nostro lavoro. Tuttavia, ho scelto di scrivere un manifesto materialista, nel tentativo di riappropriarmi del termine materialismo, spesso associato a un’accezione negativa legata al consumismo vuoto. Eppure, la nostra società si è evoluta attraverso la conoscenza e la manipolazione dei materiali, che ci hanno permesso di creare l’ambiente in cui viviamo e, di conseguenza, di definire il quadro della nostra civiltà.
Abbiamo quindi intrapreso un viaggio attraverso la storia dei materiali, partendo dalla pietra – il materiale primordiale delle caverne e dell’età della pietra – e riscoprendola oggi come un materiale straordinariamente sostenibile, resistente e cruciale. Abbiamo poi esplorato la terra cruda, il mattone, il cemento, l’acciaio e, nel numero di aprile, il vetro. Ogni numero è dedicato ai pionieri di questi materiali, in una ricerca che mostra come ogni risposta progettuale sia sempre vincolata ai materiali con cui viene realizzata.
Ogni materiale offre possibilità, ma impone anche limiti. Oggi, con la necessità di ridurre l’impronta di carbonio dell’industria edilizia, l’energia impiegata nell’estrazione e nella produzione dei materiali diventa un fattore determinante. Il calore richiesto per fondere acciaio e alluminio, così come le emissioni di CO2 prodotte dalla calcinazione del calcare per ottenere cemento, rendono la scelta del materiale una questione centrale nella sostenibilità.
Ad ottobre dedicheremo un intero numero ai re-materials, materiali recuperati da edifici esistenti e riutilizzati, fino all’idea di non costruire affatto, ma di trovare sempre nuovi modi per riadattare le strutture esistenti. In questo senso, la sostenibilità non è solo una necessità, ma anche un’opportunità straordinaria per l’arte, l’estetica e l’innovazione tecnica.
City Wave a Milano e il nuovo stabilimento San Pellegrino sono i due progetti attualmente in corso in Italia. City Wave reinterpreta il concetto di edifici gemelli che caratterizzano i passaggi urbani, proponendo due spazi lavorativi collegati da una copertura a pannelli fotovoltaici e da una struttura in legno lamellare, che insieme creano un'area pubblica ombreggiata e riparata. Il nuovo stabilimento San Pellegrino trae ispirazione dagli archi monumentali degli acquedotti, utilizzando grandi archi in cemento per creare ampie campate destinate agli spazi produttivi. Entrambi incarnano elementi essenziali dell’architettura italiana: il varco e l’arco.
Se dovessi sognare, la mia fantasia sarebbe ispirata dall’estrazione della pietra rossa marinace. Lo scorso anno ho visitato le cave di marmo di Carrara e le cave di travertino a Tivoli, rimanendo affascinato dalla loro maestosità. L’idea di realizzare una casa creata puramente eliminando spazio da una montagna di marmo, scolpendo il vuoto all’interno del monte è un progetto che voglio assolutamente realizzare prima di morire.


 Storie
Storie