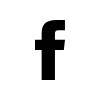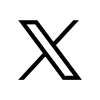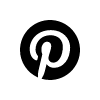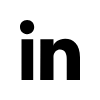Funzionalità e bellezza non hanno età. Alcuni oggetti restano attuali e iconici nel tempo anche dopo tanti anni. Un anniversario diventa così la conferma di un valore che continua a parlare al presente
Nello studio di Martino Gamper, l'intervista

Impegnato in commissioni private e in una prossima mostra a New York, il designer trentino di stanza a Londra ci apre, quasi senza preavviso, le porte del suo studio-laboratorio
Entrare nel mondo di Martino Gamper è un po’ come mettere piede nel retrobottega o nel laboratorio di un falegname. Avverti il senso e l’urgenza del fare, lo spirito creativo che si confronta con la pratica. È un luogo in cui si condivide tanto, se non tutto, della giornata. Lo spazio è occupato da un lungo tavolo in legno per il lavoro (ma non solo) e, ai lati, da una libreria e una cucina – tutto progettato e autoprodotto. Accanto, il laboratorio è un melting pot di prototipi, opere, attrezzi di ogni genere. Si percepiscono accenti di colore un po’ dovunque.
Lontanissimo dai luoghi ipertecnologici di molti designer, la stamperia di Hackney, in cui Gamper ha costruito il suo nido professionale e personale, sembra un luogo antico, dove non solo il “saper fare” risulta evidente, ma anche l’amore per questo lavoro e l’empatia e il rispetto per il team che lo accompagna. Si racconta, Martino, mentre il profumo familiare di pasta al sugo ci raggiunge. Perché qui, come si diceva, lavorare significa condividere un pezzo di vita insieme.

Sono arrivato al Royal Collage nel ’97 con il programma Erasmus e poi l’ho frequentato per due anni e sono rimasto. Ma non ho mai tagliato i ponti con l’Italia e mantengo stretti rapporti con l’industria e le gallerie italiane.
Credo quattro o cinque, ma sono qui da 15 anni. All’inizio, si trattava di laboratorio con annessa piccola camera da letto, oggi è strutturato con due ambienti contigui ma separati.
Sono un designer che lavora sia artisticamente sia artigianalmente. Nel mezzo sta la creatività e la libertà di espressione. Alcuni miei oggetti, destinati a gallerie e musei, sono sicuramente più “arte”, altri rientrano nella logica della produzione di design. Poi ci sono le sperimentazioni, veri e propri prototipi artigiani. Tutte e tre le dimensioni sono importanti e coesistono.
Dipende dal contesto e dalla strada che prende un progetto. A volte parti dal prodotto, poi aggiungi elementi più artigiani o artistici che lo rivoluzionano; altre volte, inizi da un’idea che consideri talmente artistica che poi ci ripensi e rientri nelle “regole”.
Per me non ci sono confini ma esistono mercati diversi. A volte collaboro con mia moglie (ndr l’artista Francis Upritchard) e nessuno di noi si pone limiti o prevale. E, a dire la verità, sono tutte “arti”, che siano applicate, visive, artigiane...

Stiamo tutti cercando di trovare una nuova logica in cui consumare meno ma meglio, in cui agire in modo più sostenibile. Da designer, penso si debba non solo produrre meno, con più qualità, ma anche creare oggetti con cui davvero ci identifichiamo. Abbiamo bisogno di una nuova visione: come conciliare la storia del design e la grande produzione con le nuove storie che vogliamo raccontare? Penso che si debba operare un transito, che non può essere “veloce” ma lento e importante.
Potrebbe essere una visione di cui anche loro non sanno nulla, che non avvertono ancora, una sfida nuova o una reinterpretazione inedita di qualcosa che c’è già.
Mi interessa il collegamento tra il pensare e il fare. Mi piace esaminare un’idea e poi trasformarla in oggetto. Qui, come vedi, c’è la parte intellettuale, accanto abbiamo il laboratorio. E io faccio di continuo avanti e indietro.
Come artista trovo ispirazione ovunque, tengo gli occhi aperti sul mondo 24 ore su 24, le antenne dritte anche di notte. Non credo ci sia un luogo o un momento specifico in cui cercare l’illuminazione. Io, per esempio, ho un quaderno su cui annoto ogni idea come in una continua ricerca, in cui a tratti emergono spunti che ti fanno capire che quella è la direzione corretta da prendere.
Assolutamente scevro da schemi, rituali o modelli. Assorbo tutto quanto mi circonda e reagisco alle idee finché il meccanismo si mette in moto.

Mi metto a fare. Quando non sai come superare certi “stop”, è tempo di mettersi a fare, sbagliare, ricominciare, parlare, andare in bottega, scatenarsi in maniera fisica, perché il foglio bianco non aiuta.
Ascoltiamo una stazione online londinese, la NTS, che trasmette sound di tutti i generi da tutto il mondo e poi un dj, Charlie Bones, che trasmette qui accanto, da un piccolo negozio.
Una cucina (ride)! Cucinare è un modo di stare insieme, condividere e dividere la giornata con i ragazzi con cui lavoro e con cui non si tratta mai solo di “lavorare”.
La Superleggera di Gio Ponti e la Tonietta di Enzo Mari. A parimerito.
Parliamo tanto di materiali green, riciclo e così via, ma poco di quanto il nostro lavoro sia sostenibile per noi stessi. Ci piace lavorare in questo modo? È soddisfacente dal punto di vista economico? Ci fa sentire realizzati? Esprime chi siamo? Ecco, se ognuno svolgesse un lavoro “sostenibile” per proprio ben-essere, poi sarebbe naturalmente più aperto alla sostenibilità per l’ambiente che non può iniziare in negozio. Inizia da sé e da casa propria.