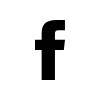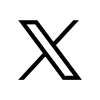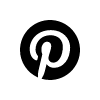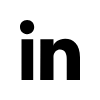Acquisti intelligenti e sostenibili: come sfruttare al massimo il bonus elettrodomestici e come richiederli. Requisiti, importi e limiti da conoscere

Torre della Permanente, Milano, Park Associati
Da Milano a Torino, passando per l’isola di San Giorgio a Venezia. Un viaggio alla scoperta di luoghi unici che almeno una volta nella vita vale la pena visitare
In Italia ci sono infinite storie bellissime di riqualificazione e di recupero e sceglierne alcune significa essere consapevoli di raccontare solo una microscopica parte di una sorta di rinascimento perenne che molti Paesi ci invidiano. Abbiamo quindi fatto un piccolo viaggio partendo da un borgo - e da dove altrimenti? - e passando per grandi città come Milano e Torino fino ad arrivare all’affascinante isola di San Giorgio a Venezia, ascoltando chi queste storie le ha pensate e rese realtà, avendo in mente un comune denominatore: creare nuovi spazi di incontro e di cultura, dare nuova vita al passato attraverso chiavi di lettura ed elementi estremamente contemporanei che facciano convivere antico e moderno. Del resto tutto fa parte di quello che Gio Ponti nel suo libro (o meglio, “collezione di idee”) “Amate ‘l’architettura” (Quodlibet 2022) definiva “quel teatro che non chiude mai, gigantesco, patetico e leggendario, nel quale noi ci muoviamo, personaggi - spettatori vivi e naturali in una scena “al vero” inventata ma vera .. l’architettura crea lo scenario della Storia, al vero, parla tutti i linguaggi.”
Palazzo senza tempo, Peccioli, MCA – Mario Cucinella Architects
Peccioli è un borgo medioevale toscano che si è aggiudicato il riconoscimento di Borgo dei borghi 2024, ed è proprio qui che Mario Cucinella Architects ha avviato un progetto di riqualificazione con l’obiettivo di legare passato, presente e futuro, creando un ponte tra la memoria storica di un luogo e la nuova vita che questo può assumere. “Qui, abbiamo lavorato al recupero di un edificio quattrocentesco e alla riqualificazione di un palazzo diroccato sottostante, trasformandoli in un complesso capace di ospitare residenze pubbliche e spazi polivalenti per eventi, mostre e momenti di socialità. - come afferma Cucinella stesso. “L’obiettivo del nostro intervento, nato in risposta al desiderio dell’Amministrazione Comunale di valorizzare il patrimonio di questo borgo medioevale toscano, era quello di rendere un’architettura storica parte della vita contemporanea, facendola dialogare con la realtà circostante e la sua quotidianità. Per dare forma a questo dialogo, abbiamo progettato una maestosa terrazza sospesa di 600 mq, con uno sbalzo da terra di circa 20 mt, che domina la facciata: un innesto contemporaneo tra i due edifici storici, affacciato sul paesaggio collinare e pensato per offrire alla comunità una nuova piazza pubblica”. L’intervento, realizzato con coraggio e gentilezza, ha previsto poi la creazione in copertura e facciata di aperture che offrono nuovi punti di vista dal cuore dell’edificio verso l’esterno. L’inserimento di lucernai e bow window consente alla luce naturale di illuminare gli interni, favorendo così un legame continuo e vivo con il territorio. Dall’edificio diroccato sottostante è nato, invece, un nuovo volume architettonico, incastonato ai livelli -1 e -2 e caratterizzato da un gioco di trasparenze, che creano un effetto di leggerezza e continuità visiva con la Valle dell’Era. Il risultato è così un complesso architettonico che non solo restituisce vita a due edifici storici, ma dona a Peccioli un luogo d’incontro e una visione rinnovata, capace di dialogare con il passato e proiettarsi verso il futuro.

Palazzo senza tempo, Peccioli - Ph. Andrea Testi
Gallerie d’Italia, Torino, AMDL CIRCLE e Michele De Lucchi
Per la sede museale delle Gallerie d’Italia – Torino, AMDL CIRCLE ha progettato uno spazio culturale ipogeo, trasformando le sale sotterranee di Palazzo Turinetti, precedentemente legate all’attività bancaria (archivi, caveau, sale meeting, parcheggi), in spazi per valorizzare e raccontare le opere di fotografia e video-art. Il progetto rigenera lo spazio ipogeo del palazzo, poco utilizzato e conosciuto, invitando a riflettere sul potenziale dei locali sotterranei, solitamente considerati come accessori, che nel lavoro per le Gallerie d’Italia – Torino sono rigenerati e attrezzati come sale espositive. Un museo sotto terra offre inoltre enormi vantaggi per la conservazione delle opere, in particolar modo del materiale fotografico, perché è possibile mantenere una temperatura e un’umidità corrette con un importante risparmio energetico. Si accede al museo da una gradinata monumentale, ritagliata nel cortile interno, che accompagna nelle sale ipogee. La gradinata è anche una platea e un luogo di socialità: sugli ampi gradini in pietra di Luserna è possibile sedersi, incontrarsi, partecipare a presentazioni e fermarsi per ammirare le opere esposte lungo la discesa. Il quadrilatero della corte, un tempo a uso privato della banca, gioca invece un ruolo fondamentale nel progetto: diventa il punto di accesso al museo, ma anche una piazza aperta alla collettività e un inedito snodo che collega via XX Settembre a piazza San Carlo. La simmetria architettonica del quadrilatero è enfatizzata dall’installazione di un colonnato in legno, sulla parte sinistra della corte, che riprende il disegno del porticato in pietra dal lato opposto. La scelta del legno, materiale d’elezione dei progetti di AMDL CIRCLE, per un inserto architettonico così evidente dichiara la volontà di lasciare un segno e riporta l’attenzione sull’autenticità del porticato in pietra.

Gallerie d’Italia, Torino - Ph. MarcoTacchini
Torre della Permanente, Milano, Park Associati
Lo studio Park Associati, fondato e guidato dagli architetti Filippo Pagliani e Michele Rossi, è noto per i suoi progetti di riqualificazione (tanto da aver vinto il Premio Architetto dell’anno 2024, riconoscimento promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, per l’intervento di retrofitting che ha portato alla realizzazione della Luxottica Digital Factory). Tra i progetti che hanno più a cuore c’è quello della Torre della Permanente per cui è stato riqualificato ed ampliato l’edificio esistente progettato negli anni Cinquanta da Achille e Pier Giacomo Castiglioni e Luigi Fratino, conferendo una migliore efficienza nel rispetto della preesistenza d’autore. La rimozione delle superfetazioni e l’adeguamento alle attuali necessità impiantistiche e alle richieste prestazionali dell’involucro, ha consentito, ove possibile, di ridurre al minimo l’impatto degli interventi e di creare degli elementi ad hoc che vadano a integrarsi col progetto originale. L’ampliamento consiste in un innesto, il cui fronte vetrato richiama la tradizione milanese delle torri del dopoguerra, generando un volume che si pone a coronamento dell’edificio. “È sempre un privilegio intervenire su edifici d’autore del Moderno milanese - racconta Filippo Pagliani, Founding Partner Park Associati. “Recupero e riqualificazione sono temi cruciali per Park Associati da sempre. Sono progetti che implicano la capacità di agire con estremo garbo nei confronti dell’esistente ai fini di non snaturare la visione originale. Nel caso della Torre della Permanente abbiamo cercato di mantenere ed esaltare la pulizia formale delle linee dell’edificio, andandone a sottolineare il rigore compositivo. L’intervento è una rinnovata sfida al confronto con le architetture più importanti del Novecento italiano, perché continuino ad essere protagoniste del tessuto urbano contemporaneo, con la consapevolezza che l’edificio più sostenibile è quello che già esiste”.

Torre della Permanente, Milano - Ph. Francesca Iovene
Padiglione della Santa Sede, Isola di San Giorgio Maggiore, More e Moretti spa
L'architetta Valentina Moretti, fondatrice e direttrice creativa di More e Vicepresidente di Holding Terra Moretti, ha contribuito alla realizzazione del primo Padiglione della Santa Sede alla Biennale di Architettura di Venezia, “Vatican Chapels”, un progetto di alto valore culturale promosso dal cardinale Gianfranco Ravasi e curato dal prof. Francesco Dal Co e dalla dott.ssa Micol Forti. Ispirato alla Cappella nel bosco di Gunnar Asplund, il progetto esplora la spiritualità contemporanea attraverso dieci cappelle progettate da architetti di fama mondiale e realizzate nell’ambiente naturale dell’isola di San Giorgio Maggiore, sede della Fondazione Giorgio Cini. More e Moretti SpA hanno portato la loro esperienza nella prefabbricazione per creare due cappelle distintive: quella in cemento armato progettata da Smiljan Radic e quella in legno lamellare ideata da Andrew Berman. Questi interventi esprimono un profondo rispetto per il contesto naturale, integrandosi con l’isola come episodi di architettura che dialogano con il paesaggio e lo arricchiscono senza invaderlo. L’architetta Moretti riflette sull’impatto tangibile delle buone architetture sul territorio e su come queste possano “contaminare” positivamente lo spazio, rendendo la relazione tra costruito e natura un pilastro della progettualità. Le cappelle, pensate per un riuso al termine dell’esposizione, sono aperte alla cittadinanza, offrendo un luogo di contemplazione e scoperta in un “bosco sacro” che esalta l’incontro tra spiritualità e architettura.

Padiglione della Santa Sede, Isola di San Giorgio Maggiore
Collegio di Milano, Piuarch
Vincitore del concorso promosso dalla Fondazione Collegio delle Università Milanesi, il progetto per i nuovi alloggi del Collegio di Milano cerca un dialogo forte e rispettoso con l’edificio esistente, disegnato da Marco Zanuso negli anni settanta come centro per l'assistenza ai Paesi africani. L’intervento parte da un’approfondita e attenta analisi delle funzioni al suo interno e della relazione con l’edificio esistente, rispettandone le altezze, i colori e riprendendone la forma ramificata. Un approccio che sottolinea analogie morfologiche e di impianto complessivo, senza risultare ripetitivo. Le 50 unità abitative del nuovo intervento sono disposte in due blocchi continui rivolti uno a sudovest e l’altro a sudest, con affacci privilegiati e mai contrapposti a quelli esistenti, per guadagnare una esposizione ottimale delle stanze. Ciascun alloggio si affaccia sull’esterno con una grande vetrata, in parte fissa, che arretra rispetto al profilo della facciata, lasciando lo spazio per un terrazzo di pertinenza. Il pattern variato delle aperture di diverse dimensioni ritma e alleggerisce le facciate continue, lunghe circa 70 m, in cui la luce riveste un ruolo fondamentale per gli spazi interni. Anche l’intensità delle aperture e l’alternanza tra pieni e vuoti cambia a seconda dell’ambiente interno corrispondente: le vetrate degli alloggi sono ampie e creano grandi fori di luce, mentre diventano sempre più piccole al passaggio dagli spazi abitativi a quelli di ritrovo e di circolazione. Gli spazi interni sono strutturati in modo da essere molto flessibili, rifiutando il classico schema distributivo corridoio-stanza. I luoghi di passaggio da un ambiente all’altro sono strutturati per essere modificabili dall’uso e diventare punti di incontro e zone di ritrovo.


 Storie
Storie