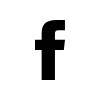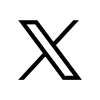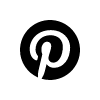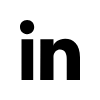Modulari, confortevoli, dall’estetica ricercata e con dettagli sartoriali: ecco una selezione di elementi d’arredo pensati per rendere ogni ambiente domestico davvero unico
Re-Discovered, a Milano il design è ovunque

Milano, veduta panoramica della città
Durante i giorni del Salone del Mobile.Milano, una serie di QR code sarà apposta in città accanto a oggetti e luoghi che hanno reso iconico lo spazio pubblico. Un invito a (ri)scoprire le storie d’eccezione dietro a questi progetti
Si dice spesso che il fascino di Milano scaturisca dai suoi luoghi privati, si tratti dei suoi bei cortili o di case e appartamenti arredati con cura, audacia ed ironia. Eppure, nella città del design per antonomasia, anche lo spazio pubblico è puntellato di tanti iconici progetti che contribuiscono a definire – e far amare – il volto unico di questa città. A volte, questi arredi urbani o questi luoghi emblematici sono noti al grande pubblico, incarnandosi nella vita quotidiana dei milanesi (e non solo). In altri casi, però, la loro presenza è più discreta: rischiamo di passarci accanto senza che ne possiamo conoscere la storia e le circostanze che hanno contribuito a dargli la forma, la funzione e la collocazione che ha.
Per ravvivare la memoria dei cittadini di Milano, ed accompagnare i tantissimi visitatori che vi si recano ogni anno, il Salone del Mobile.Milano ha predisposto un progetto per riscoprire dei gioielli urbani della città meneghina. Re-Discovered consente di scansionare i QR code posizionati accanto ad alcune grandi icone per scoprirne la storia. Un invito a riscoprire le qualità e l’unicità di Milano: per capire che la capitale mondiale del design non eccelle solo per gli arredi e i prodotti a cui dà vita ogni anno, ma anche per le soluzioni innovative che la trasformano in un museo a cielo aperto, dove il design è di casa ovunque.

Corrimano Metro Milano M1/M2, Franco Albini e Franca Helg, 1964
È forse il simbolo che più ha concorso a definire l’identità della linea 1 della metro milanese, la celebre “rossa” inaugurata nel 1964. Il suo corrimano, in tubolare metallico verniciato, si dipana come un fil rouge – o meglio come un “filo di Arianna”, secondo una definizione che gli è stata attribuita - per tutto il percorso che va dal piano strada al binario, accompagnando il viaggiatore nei suoi spostamenti. Una cifra di semplicità ed eleganza è anche il modo in cui il corrimano termina, delineando attraverso la doppia curvatura del tubolare un’iconica “P”. La stessa che ritroveremo, qualche anno più tardi, anche nel corrimano della nuova M2.

Segnaletica e allestimento visivo Metro Milano M1, design Bob Noorda, 1964
È un progetto che ha fatto scuola in tutto il mondo, contribuendo ad affermare l’idea che segnaletica ed architettura debbano essere pensate in maniera integrata, seguendo un approccio sistemico. Superando l’utilizzo del cartello come unico modo per comunicare il nome della stazione, Bob Noorda progetta una lunga linea rossa che corre lungo tutto il binario e che ripete il nome della stazione ad intervalli regolari: un aiuto prezioso per i viaggiatori dentro i vagoni, che spesso fanno fatica a capire a quale fermata sono arrivati. Anche il carattere tipografico scelto da Noorda, l’Helvetica, fu parzialmente ridisegnato per garantire maggiore leggibilità. Il progetto della metro milanese ha vinto il Compasso d’Oro nel 1964.

Panettone in cemento, Enzo Mari, 1980
Come conferire anche agli oggetti più banali una forma in grado di rispondere con intelligenza al contesto d’uso e all’economia di mezzi disponibili? La sfida non poteva che calzare come un guanto ad Enzo Mari, grande maestro del design italiano per il quale ogni progetto era legittimo ed esigeva coerenza, utilità, elevazione. Consulente per l’arredo urbano del Comune di Milano, nel 1980 Mari è chiamato a realizzare dei dissuasori di parcheggio per Corso Vittorio Emanuele, che sta per essere pedonalizzato. La sua risposta, un levigato cilindro di cemento sormontato da una cupola, offre un peso a prova di furbetto, intorno ai 100 kg, e si distingue per la presenza di un foro centrale che facilita lo spostamento tramite muletto. Chiamato Panettone, un omaggio al dolce di Milano, il dissuasore di Mari è ancora oggi in funzione ed è stato adottato su larga scala in tutta Italia.

Tombino, Giulio Iacchetti e Matteo Ragni, Montini, 2012
Spesso definito come il primo tombino “di design”, il progetto di Iacchetti e Ragni rilancia questa tipologia progettuale oltre la dimensione del design anonimo. A fare la differenza è un’intuizione ben precisa: le texture che distinguono la superficie dei differenti modelli non sono solo l’esito di un processo decorativo, ma un modo per raccontare una storia, come l’irruzione di una ruota o il passaggio di un uccellino, o per mettere in evidenza la grana della materia con cui sono realizzati, la ghisa.